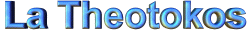
Paradigma eucaristico-mariano e carenza di bellezza
Data: Venerdi 11 Giugno 2021, alle ore 18:28:47
Argomento: Società
Da Michele Giulio Masciarelli (†11 giugno 2021),
Maria e l'Eucaristia dinnanzi alle carenze umane, in AA. VV., Maria e
l'Eucaristia, Centro di Cultura Mariana "Madre della Chiesa", Roma 2000,
pp.107-117. 
|
In Memoriam
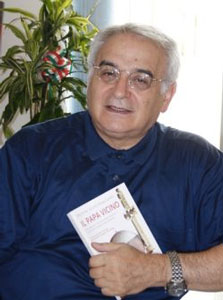 |
|
L'11 giugno 2021, è deceduto, all'età di
77 anni, Mons. Michele Giulio Masciarelli. Si era laureato in Teologia presso la Pontificia università Gregoriana di Roma, in Filosofia alla d’Annunzio di Chieti nel 1976, in Diritto Canonico alla Pontifica università Lateranense. Aveva insegnato anche all’Istituto Teologico Abruzzese–Molisano al seminario regionale di Chieti.
Nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto è stato viceparroco e parroco, assistente della Fuci e dei laureati cattolici, vicario episcopale per la cultura e l’ecumenismo e, in seguito, per il sinodo diocesano. Autore di svariati volumi, aveva approfondito il pensiero teologico di Joseph Ratzinger.
Ecco alcune sue pubblicazioni dedicate alla Vergine:
- Pio IX e l'Immacolata,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000;
- L' innocente. Maria, l'Immacolata, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2000;
- La maestra. Lezioni mariane a Cana,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002;
-
Il segno della donna. Maria nella teologia di Joseph Ratzinger,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2007;
- Col cuore della madre, Rogate, Roma 2009;
- La Bellissima. Maria sulla «via pulchritudinis»,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012;
- La discepola Maria di Nazaret beata perché ha creduto,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018;
-
Riforma sinodale. In compagnia della discepola, Tau Editrice,
Todi 2018 |
È venuto il momento di confrontarci sul nostro stato di
bellezza, perché la verifica della nostra autenticità passa anche
per tale controllo, se è vero che la bellezza è essenziale alla
decifrazione e alla realizzazione della verità dell’uomo. Anzi,
tutte le cose, nel senso più ampio del termine, fanno naturalmente
riferimento alla bellezza: «La bellezza sta alle cose come
la santità sta all’anima».127
La bellezza è categoria fondamentale dell’essere, della
natura, dell’uomo, di Dio stesso. Essa per solito la si considera
come un elemento accessorio e non necessario, della realtà. Ma
c’è da chiedersi se, mancando d’interrogarci sulla bellezza, sappiamo abbastanza della realtà e se, per caso, c’impediamo di
conoscere un elemento essenziale di essa. Ma la bellezza cos’è?
In forma abbreviata, essa può essere definita come «trasformazione
della materia per mezzo dell’Incarnazione, in essa, di un
principio, sopramateriale».128 Ma non è questa l’avventura costante
della vita dell’uomo?
a) Siamo in un mondo senza bellezza?
Rovesciando i termini
che costituiscono e fanno riconoscere la bellezza, possiamo
farci un’idea anche del suo contrario, la bruttezza; questa è ciò
che non allude a nulla di superiore, di trasparente, di elevante,
di trascendente, ma esprime, ad un tempo, solo la naturalità
della natura, l’animalità dell’animale, la temporalità del tempo.
Quanta bruttezza c’è nel mondo? Quali sono le sue presenze
più nocive e più urgenti da rimuovere?
È difficile rispondere a queste domande, perché anche il
brutto, da un certo punto di vista, è poco conosciuto. Paradossalmente,
il brutto è molto praticato, ma poco conosciuto;
anzi, proprio perché è poco conosciuto nel suo carattere devastante
(si pensi alla sua nocività in campo educativo) è molto
praticato e diffuso.
Sembra si possa affermare che la bruttezza sia percepibile
in tre situazioni: quando si frattura ciò che s’intuisce debba
essere unito; quando la sproporzione prende il posto della
misura; quando le cose, le persone e gli eventi s’addossano fra
loro, scomparendo ogni distanza. Tenendo presente questo
paradigma, andiamo a constatare che oggi c’è un’enfasi del
brutto dalle proporzioni assai ampie, per cui esso appare, fra
l’altro, oltre che infastidente e repellente, anche vistoso e ingombrante.
Molte situazioni umane, spirituali e culturali sono brutte
proprio perché recano i segni della lacerazione e della separazione:
– la frattura tra passato, presente e futuro: (la cultura di
oggi è rimasta impigliata in un bieco presentismo);
– la frattura tra la strada e l’orizzonte: (l’uomo di oggi solo
di rado aggiunge alla passione del «come» la preoccupazione
del «perché»);
– la frattura tra il «particolare» e la «totalità»: (la cultura dei
nostri ultimi decenni è calamitata dal primo ed evade nevroticamente
dalla seconda);
– la frattura tra la natura e l’umano: (la nostra cultura «vitalistica» o oppone queste due polarità del reale o le assorbe
dentro un orizzonte «biocentrico» che oscura le eccedenze di
tipo personologiche);
– la frattura tra l’umano e quanto sorpassa l’umano: (la cultura
odierna fatica ad uscire dalla pelle del suo umanesimo unilaterale
che le impedisce di tentare l’ipotesi di un’apertura
metastorica e «sovrumana»);
– la frattura tra etica privata ed etica pubblica: (sono vistose
e doloranti le ferite procurate da questa scissione in tanti campi
dell’umano);
– la frattura tra esigenza etica e verità dell’etica: (quando l’esigenza
etica s’affievolisce, si scivola nell’esteriorismo etico);
– la frattura tra complessità e unità della vita: (si preferisce
fuggire pavidamente da «Babele», piuttosto che riconciliare
«Babele» con percorsi spirituali e culturali che permettano la
riconquista del senso pieno e ultimo dell’esistere);
– la frattura tra fare e contemplare: (non si sa più optare tra
ciò che è effimero e ciò che è necessario, tra le cose che passano
e le cose che restano);
– la frattura tra vita e amore: (s’è imposto il convincimento
culturale secondo cui ciò che conta è il piano naturale del vivere,
mentre l’amore non avrebbe con la vita nessun legame
oggettivo, ma solo ideologico e, magari, fideistico);
– la frattura tra vita e morte: (l’idea della morte non è più
nel cuore della vita e non è più il paradigma dei limiti invalicabili degli uomini o la pietra di paragone delle differenze, il criterio
di giudizio rispetto a tutto ciò che è effimero e non autentico).
Anche la seconda causalità del brutto (la perdita della misura)
mostra oggi la sua infelice filiazione. La disarmonia è il
fondale fisso della vita quotidiana: non c’è il rispetto del tempo
giusto; il tempo è come intasato, compresso di atti, parole,
intraprese sgarbate, scorbutiche. Il tempo è bistrattato, strapazzato:
non c’è più nessuna concessione alla lentezza, che pure ha
il suo ritmo saggio e benefico. Un musicista non può eseguire
tutto con moto veloce: conosce, invece, i tempi lenti, lentissimi,
i movimenti brevi, i tocchi lievi. Così è per un pittore, per
uno scultore, per un ginnasta. E come è possibile che appaia
bella la forma della nostra vita che troppo spesso precipita da
un eccesso all’altro, senza pacatezza, senza pause, senza controllo,
senza contemplazione?
Il parlare immoderato, più che esplicito; il dire senza ritegno
più che con sincerità; lo scoprimento impudico dei sentimenti,
la fine della riservatezza, la rinuncia alla discrezione,
l’abbandono di regole comportamentali che servivano l’intenzione
di esprimere raccordo gerarchico, tatto educativo, delicatezza
d’amicizia e tant’altri approcci sfumati a persone e cose,
vanno identificati come sintomi di bruttezza.
La perdita della distanza, che pretende d’accorpare proprio
ciò che è spirituale, compie il resto.129 È ancora il brutto
che dal di dentro dello spirito passa al di fuori dei comportamenti: solo di rado si sa essere riservati nel rapporto con gli
altri, sobri nell’interrogare, eleganti nel comportarsi; non c’è
più posto per l’intelligente ironia, per l’allusione sfiorante il
problema, per l’uso garbato del «diminutivo»: tutto è subito
palese, dichiarato, gridato. Sono cadute troppe difese che proteggevano
la bellezza, e il brutto ha tracimato, a ondate devastanti:
si sono imposti l’anonimato, la volgarità, la pesantezza,
l’impersonale.
b) L’Eucaristia, icona di bellezza
La bellezza dell’Eucaristia?
Sì, l’Eucaristia è la mensa bella, il Pane bello. Il pane,
modesto nella moltitudine delle cose e normale nella vita dell’uomo,
è salito nella storia della salvezza e per volontà di Cristo
ad altezze vertiginose, quelle del «miracolo eucaristico» che
accade in ogni Messa, quando il pane diventa corpo di Cristo.
«Portato a queste altezze, il pane è diventato così profondamente
suggestivo, da riapparirci non soltanto come la nuova
incarnazione di Cristo in ogni uomo che lo mangia, ma la
stessa rivelazione di Lui. C’è un luogo nel Vangelo dove il
pane ha assunto la mirabile funzione di strumento di conoscenza.
Voi avete già pensato alla Cena di Emmaus, nella
quale Cristo mangia il pane con i suoi discepoli, in un primo
tempo dubbiosi, smarriti; ma alla fine, comprendono, riconoscono
in Lui il Maestro risorto; non tanto dalle parole che
dice quanto dal gesto che compie, spezzando il pane. “In
fractione panis cognoverunt eum”. La nostra suggestione
aumenta, si fa più inevitabile. Dopo che Dio si è incarnato
nel pane, ci pare che ogni pane debba essere pieno di Dio e
della sua mistica presenza. È sempre commossa la scena della
famiglia raccolta intorno alla mensa sulla quale non può mancare
il pane. E la mensa ne splende».130
Ma la suggestione, la bellezza della mensa di famiglia crescono
per la presenza della madre: una famiglia senza madre
non è bella pienamente, nemmeno quando è radunata intorno
alla mensa che splende della bellezza del pane. La bellezza della mensa eucaristica è però sempre armonizzata con la bellezza
di Maria che non lascia sola la Chiesa nel gesto più serio e
solenne che questa compie. Della bellezza di Cristo Agnello
eucaristico risplende in maniera speciale Maria, chiamata, con
espressione cristologicamente allusiva, «la bella agnella» da un
antichissimo testo cristiano.131
c) Maria, via di bellezza al cristianesimo
Maria si offre allo
sguardo credente della Chiesa nello splendore della grazia redentiva di Cristo e ci attrae:
«Maria è la creatura “tota pulchra”: è lo “speculum sine macula”;
è l’ideale supremo della perfezione che in ogni tempo gli
artisti hanno cercato di riprodurre nelle loro opere; è “la Donna
vestita di sole” (Ap 12, 1), nella quale i raggi purissimi della
bellezza umana si incontrano con quelli sovrani, ma accessibili,
della bellezza soprannaturale».132
Maria appartiene all’umanità creata nell’innocenza e nella
piena conformazione a Cristo. Questa condizione di creatura
nuova non l’allontana dal resto dell’umanità: la sua non è grazia
di separazione dagli uomini, quanto piuttosto di possesso
pieno di una umanità integra e densa di mistero. La sua grazia
originaria è anzitutto grazia di pienezza e non di separazione.
Maria è santificata in previsione dei meriti futuri di Cristo, ma
lo è in modo speciale in ragione della sua relazione immediata
con suo Figlio, fonte di grazia, in vista del quale tutto è stato
creato.
Nella bellezza di Maria, l’immacolata e la piena di grazia, è
contemplabile la bellezza dell’intera umanità: in essa l’umanità
è restituita all’originaria innocenza e alla bellezza primigenia, e
si compie realmente il simbolo della vergine terra. Perciò, sulla
via creationis, noi troviamo in Maria l’umanità integra, pura,
buona, armonica, di nulla mancante, di tutto ricca e adorna. La causa di questa pienezza d’umanità santa è data dalla sua vicinanza
a Cristo: Maria è Eva più di Eva per il forte vincolo che
ha Cristo, che è Adamo più di Adamo.
Maria è immacolata perché Cristo è santissimo; è piena di
grazia perché Cristo con la sua redenzione è la causa di ogni
santità; è Tutta bella perché è la madre del Re messianico, che è
«il più bello tra i figli degli uomini» (Sal 44,3):
«È come la luna; se si spegnesse il sole non la vedremmo più,
se invece è splendente, lo è perché i raggi del sole battono su
di lei. Così, se la Madonna ha tutte le grazie, le bellezze, la
santità, la virtù, le ha perché è unita a Cristo come nessun’altra
creatura: Cristo è la sorgente di tutte le bellezze e le grazie
di cui rifulge Maria».133
Nessuna creatura, neppure Maria, è bella da sé: è Dio
«l’autore della bellezza» (Sap 13, 3) che crea la «bellezza delle
creature» (Sap 13,5). Dio, il Santo e il Vivente, è la Bellezza
suprema e le sue opere sono «belle-buone» (cf. Gn 1,9.12.25.
31): fra queste spicca Maria.134 È soprattutto la condizione di grazia dell’Immacolata Concezione a rendere bella Maria. La
bruttura del male è del tutto esclusa da Maria ed è questo che
la rende così bella. È per tale motivo che è così piacevole contemplarla:
è creatura Trinitatis nel senso che è un prisma che
non devia la luce, ma, completamente trasparente, non trattiene
nulla della luce trinitaria che l’attraversa.
d) Ritorno alla bellezza
Maria è icona della Trinità; ciò
equivale a dire che è «via pulchritudinis» al mistero trinitario:
l’icona «permette di conoscere Dio attraverso la sua bellezza».135 Con la sua identità bella, Maria invita la Chiesa a percorrere
la via della bellezza e divenire, così, sempre di più adorna
di bellezza agli occhi di Dio,136 che è la Bellezza suprema, la
stessa bellezza e, pertanto, il bello è un ideale e un nutrimento
insostituibile per l’uomo, per la sua liberazione e affermazione
spirituale. È per questo che san Paolo chiama il cristiano a
«operare in maniera bella» (cf. 2Ts 3,13); è un invito che ha
l’aria di essere stato uno dei temi ricorrenti nelle sue conversazioni
per diffondere il Vangelo: «Prefiggetevi cose belle, non
soltanto davanti a Dio, ma anche davanti a tutti gli uomini» (cf.
Rm 12,17; 2 Cor 8,21; 13,7). E ancora: «Verificate ogni cosa,
tenete ciò che è bello» (1Ts 5, 21). Si celebra così, fin dalle origini
del cristianesimo, un’alleanza inseparabile tra il bene e il
bello, tra la morale e l’estetica.
Secondo tutti i grandi dell’umanità, da Omero ai Veda, da
Platone a Buddha, da Dante a Goethe, l’uomo si realizza soltanto
nello slancio verso il Vero, il Bello e il Bene.
«Se non ci fosse l’ideale della Bellezza, l’uomo diventerebbe
preda dell’angoscia... Ma siccome Cristo ha recato in sé e nella sua parola l’ideale della Bellezza, la decisione fu presa
una volta per sempre: meglio infondere nelle anime l’ideale
della Bellezza; custodendolo nell’anima, tutti diventeranno
fratelli l’uno dell’altro, e allora, senza dubbio, lavorando
l’uno per l’altro, essi diventeranno anche ricchi».137
Purtroppo, non si è ancora capito che la Bellezza ha in sé
una forza liberatrice ed elevatrice. Abbiamo sempre più usato,
nella filosofia e teologia occidentali, le categorie di Vero e di
Bene per interpretare e leggere la realtà e sempre meno quella
della Bellezza. Una sensibilità estetica spiccata è stata mostrata
dal pensiero orientale, che ama vedere e contemplare volti e
quadri di realtà. «La Bontà, la Verità, la Bellezza sono – afferma Soloviev –
solo diverse espressioni, diversi aspetti, diversi lati di
un medesimo essere ideale e veritiero».138 La verità è un tutto:
per accostarla occorre non solo la filosofia (= amore della sapienza),
ma anche la filocalia (= amore della bellezza).139
«Il vero e il bene non sono sufficienti a creare una cultura,
perché non sembrano sufficienti da soli a creare una comunione,
una unità di vita tra gli uomini. E poiché la cultura è
espressione stessa di uno sviluppo individuale, di una certa
perfezione raggiunta, ne viene che la cultura massimamente
sembra esprimersi nella bellezza. La bellezza è il fine di tutte
le cose».140
Oggi impera l’eticismo, ossia l’esaltazione della prospettiva
etica nella separatezza, nell’angolatura unilaterale, nella pretesa
di poter salvare l’uomo incamminandolo sulla via del bene,
senza pensare che se quella via non è bella non vi si resta nemmeno
a lungo. Si direbbe che la via del bene deve corrispondere alla via
del bello, nel senso che la via del bene se non serve anche come
“luogo” di contemplazione, come “oasi” spirituale, come “spazio”
per danzare la vita, neppure servirà per camminare verso
il Bene.
«Grande male è staccare la realtà del buono dalla realtà del
bello: sarebbe come esporsi da una parte alle degenerazioni
di un moralismo, e quindi alla falsità; ed esporsi, dall’altra,
alla tentazione di vuoti formalismi, all’incantesimo del nulla
(la “fascinatio nugacitatis” delle s. Scritture!). Potremmo dire
che da qui si dipartono i due crinali, l’uno opposto all’altro:
del “religioso” opposto all’“ateo”».141
Tuttavia, sempre di più cresce il convincimento che la Bellezza
è necessaria per la salvezza. È nella memoria di tutti la
nota espressione di Dostoevskij: «La bellezza salverà il mondo».
È un’affermazione che lo scrittore russo fa in un contesto problematico,
nel quale ammette che «la bellezza è un enigma» e
che perciò bisogna bene intendersi: quale bellezza salverà il
mondo? Salverà il mondo «non la Bellezza qualunque, ma quella
dello Spirito Santo e quella della Donna vestita di sole».142
È venuto il momento, perciò, di affidarci alla bellezza: alla
sua innocenza, alla sua gratuità, alla sua mirabile inattualità,
alla sua inefficienza, alla sua inutilità, alla sua mistericità. La
philosofia perennis l’assicurava sempre in compagnia del vero e
del buono: «verum, bonum et pulcrum convertuntur». Ma
così, purtroppo, non è stato: della sua perdita soffriamo molto
ad ogni livello e in ogni ambito: patiamo, infatti, un lungo esilio
della sua presenza fra noi.
Essa è pressoché scomparsa dalle chiese e dallo stesso
mondo. È scomparsa, conseguentemente, anche dalla teologia,
che è rimasta a modulare ieri più il vero, oggi più il buono;
eppure, l’imparentamento di queste tre parole – vero, bene e
bello – deve tornare a farsi intimo e stretto. Verità ed eticità, da sole, non bastano più per dire Dio, per pensare i rapporti dentro
la comunità credente, per progettare la missione cristiana
nel mondo: s’impone la via pulchritudinis alla salvezza. Finché
la verità e il bene non sono divenuti bellezza, la verità e il bene
sembrano rimanere in qualche modo estranei all’uomo, s’impongono
a lui dall’esterno; egli vi aderisce, ma non li possiede.
esigono da lui una obbedienza che in un qualche modo lo
mortificano.143
NOTE
127 S. WEIL,
Pensieri disordinati sull’amore
di Dio, Vicenza 1982, p. 44.
128
Cf. V. SOLOVIEV,
La bellezza della natura, in
Opere complete, IV,
Bruxelles 1966, p. 41.
129
Basti l’esempio della bruttezza che
deteriora il clima umano di diversi ambiti del mondo contemporaneo: scuola, il
lavoro, la politica, lo sport, lo spettacolo. Il desiderio di autoaffermazione e
la spinta a primeggiare s’esprimono frequentemente secondo moduli improntati ai
brutti modi del malgarbo, dell’indiscrezione, dell’arroganza, della
prevaricazione che sembrano diventati ingredienti indispensabili nella strategia
per meglio imporsi. È una malinconica degradazione dei rapporti umani e sociali
che reclama il ritorno alla
bellezza della mitezza e della cortesia, delle quali virtù non si tesse mai
a sufficienza l’elogio (cf. N. BOBBIO,
Elogio della mitezza e altri
scritti morali, Milano 1994; G. AXIA,
Elogio della cortesia.
L’attenzione per gli altri come forma d’intelligenza, Bologna 1996).
130
C. ANGELINI,
Il motivo del pane, in A. PIOLANTI,
L’Eucaristia, Roma 19602,
p. 144.
131
MELITONE
DI SARDI,
Omelia pasquale, n. 71, v.
513, in Sources Chrétiennes
123, p. 98.
132
PAOLO
VI,
Discorso per la chiusura del VI
congresso mariologico e l’inizio del XIV congresso mariano, Roma, 16. 5.
1975.
133
G. B. MONTINI,
Sulla Madonna. Discorsi e
scritti [1955-1963], Brescia-Roma 1988, p. 170. L’Immacolata Concezione
c’invita, in un modo del tutto particolare, ad andare a Maria per la
via della bellezza: Maria
Immacolata si offre al nostro sguardo credente nello splendore della grazia
redentiva di Cristo e ci attrae:
«Maria è la creatura “tota
pulchra”: è lo “speculum
sine macula” ; è l’ideale supremo della perfezione che in ogni tempo gli
artisti hanno cercato di riprodurre nelle loro opere; è “la Donna vestita di
sole” (Ap 12, 1), nella quale i raggi purissimi della bellezza umana si
incontrano con quelli sovrani, ma accessibili, della bellezza soprannaturale» (PAOLO
VI, Discorso per la
chiusura del VI congresso mariologico e l’inizio del XIV congresso mariano,
Roma, 16.5.1975). È nella memoria di tutti la nota espressione di Dostoévskij:
«La bellezza salverà il mondo». È un’affermazione che lo scrittore russo fa in
un contesto problematico, nel quale ammette che «la bellezza è un enigma» e che
perciò bisogna bene intendersi: quale bellezza salverà il mondo? Salverà il
mondo solo la bellezza redenta: quella che sorge dallo Spirito ed è
apparentata con le ultime realtà; essa opera una coincidenza tra l’esperienza
estetica e quella religiosa. Così è la bellezza dell’Immacolata (cf. P. EVDOKIMOV,
Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Roma 1991, p. 63).
134
A Maria il Figlio – immagina nella fede un
beato medievale – si rivolge in lode: «Tu
sei bella, le dice: bella nei pensieri, bella nelle parole, bella
nelle azioni; bella dalla nascita fino alla morte; bella nella concezione
verginale, bella nel parto divino, bella nella porpora della mia passione, bella
soprattutto nello splendore della mia risurrezione» (AMEDEO
DI LOSANNA, Huit homélies
mariales: Hom. VII, 234-239).
135
O. CLÉMENT,
Riflessioni sull’uomo,
Milano 19913,
p. 126.
136 Cf. 2 Cor 11, 3; Rm 16, 20; Ap
11 e 12; Lettera a Diogneto
12, 8.
137
Dostoévskij inedito. Quaderni e
taccuini 1860-1881, a cura di L. DEL
SANTO, Firenze 1980, p. 56.
138
Cf.
Ibid., p. 35ss.
139
Cf. T. SPIDLÍK,
Bellezza, in
Lessico per il Terzo Millennio, a
cura di P. PISARRA,
Supplemento a Nuova
Responsabilità, [Rivista dell’Azione Cattolica Italiana], n. 8, novembre
1995, p. 56-60.
140
D. M. TUROLDO,
Bellezza I, in
Nuovo Dizionario di Mariologia, p.
223.
141
Ibid.
142 Citato da T. SPIDLÍK,
L’idea russa, p. 297.
143
Cf. D. BARSOTTI,
Cultura e grazia, in
Ragguaglio, Milano 1960.
ASCOLTA L'AUDIO DELL'ARTICOLO

|
|