Dal libro di Stefano De Fiores, Chi è per noi Maria?, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2001, pp. 94-96.


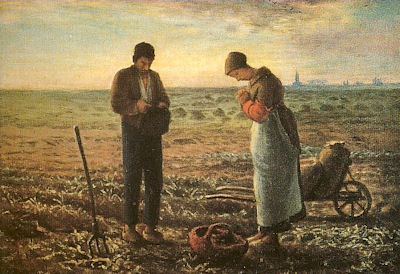
Origini dell'Angelus
Come il rosario, anche l'Angelus non sorge dall'oggi al
domani. La sua formazione dura circa trecento anni. Nel 1269 il Capitolo
generale dei frati minori considera usanza universale nella Chiesa «salutare
la Vergine con le parole dell'angelo ogni sera al triplice tocco della campana».1
A Montecassino con le costituzioni dell'abate Tommaso I
(1285-1288) subentra l'uso di suonare per l'Ave Maria alla sera e al
mattino. Nel 1327 papa Giovanni XXII concede l'indulgenza ai fedeli che al suono
delle campane recitano in ginocchio tre Ave e introduce a Roma tale uso.
La recita dell'Angelus a mezzogiorno è introdotta nel XV secolo in
memoria della passione di Gesù e per ottenere la pace. Progressivamente se ne
stabilisce la recita al suono delle campane al mattino, a mezzogiorno e a sera.
Da qualche decennio il papa recita l'Angelus ogni domenica con i fedeli
di tutto il mondo mediante la radio e la Tv.
L 'aggiunta dei versetti biblici
Quanto alla formula, le tre Ave costituiscono l'elemento più antico. Poi
si aggiungono i versetti biblici e l'orazione finale. Troviamo l'Angelus
con questa struttura in un catechismo veneziano del 1560 e nel Breviario
romano dal 1570 in poi. Pio VII nel 1815 concede l'indulgenza a chi recita tre
Gloria «ringraziando la SS. Trinità per gli esimi doni e privilegi
concessi alla beatissima Vergine». La sostituzione dell'Angelus con
il Regina Coeli nel tempo pasquale è dovuta a un intervento di Benedetto
XIV nel 1742. L'esortazione apostolica Marialis cultus di Paolo VI (1974)
invita a mantenere la recita dell'Angelus nella sua struttura semplice e
non bisognosa di restauro. Nonostante la scomparsa di alcune usanze legate a
questa preghiera, «immutati restano il valore della contemplazione del
mistero dell'incarnazione del Verbo, del saluto alla Vergine e del ricorso alla
sua misericordiosa intercessione», oltre all'«apertura verso il mistero
pasquale».2
Il centro d'interesse
Il centro d'interesse dell'Angelus è costituito dalla contemplazione del
mistero dell'incarnazione, che è compendio e superamento dell'antica alleanza:
Dio, che aveva intessuto un dialogo di fatti e parole con il suo popolo, ora si
identifica con l'uomo. É un mistero di
kenosi e di gloria: il Verbo si spoglia delle sue prerogative divine e
assume i limiti della condizione umana,3
ma nello stesso tempo irradia tra gli uomini la gloria divina.4
É un mistero salvifico, perché «per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e s'incarnò per opera dello
Spirito Santo nel seno della Vergine Maria».5
É un mistero dialogico, in cui Dio non
impone la sua volontà alla creatura ma chiede il consenso all'umile Vergine di
Nazaret.6 É infine un mistero-codice,
in quanto contiene in germe il futuro modo d'agire di Dio: la collaborazione di
Maria con lo Spirito nel realizzare il capolavoro della storia della salvezza,
cioè l'incarnazione del Figlio di Dio, che continua ogni volta che si attuano
meraviglie di grazia nella storia dell'umanità. Maria coopera con amore di madre
alla rinascita dei figli di Dio. La contemplazione di Maria in dialogo con il
messaggero celeste - come si fa nell'Angelus - ha due effetti: introduce
sempre più nel mistero del Verbo incarnato e invita a ripetere a Cristo il si
del dono sponsale: «La Chiesa, pensando a lei piamente e contemplandola alla
luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione e più profondamente
nell'altissimo mistero dell'incarnazione e si va conformando al suo sposo».7
La formula semplificata
Alcune comunità per semplificare l'Angelus, soprattutto se cantato, hanno
ridotto da tre a una le Ave e il Gloria. L'uso si è diffuso perché
la preghiera è risultata più snella e quindi più facilmente recitabile, per
esempio prima del pranzo. La semplificazione si accorda con un'esigenza della
pietà contemporanea che bada più alla qualità che alla quantità. Uno slogan del
dopo concilio propone: «Non più Messe, ma più Messa» nell'intento di
puntare a una sola Messa, ma celebrata in modo più intenso e partecipato.
É vero che così si riduce l'elemento
storicamente più antico dell'Angelus, cioè le tre Ave, ma
permangono i ricchi versetti biblici e la preghiera finale. Meglio forse che
cadano due Ave e due Gloria piuttosto che tutto l'Angelus.
L'impoverimento reale della preghiera, è invece la fretta che impedisce di
sostare pensosi - come fa la coppia di contadini immortalati nell'Angelus
del pittore Jean-Francois Millet - in vera meditazione del Dio incarnato nel
grembo di una giovane donna di Nazaret che lo accoglie con fede.
96
I
NOTE
1 Annales Minorum, IV, 33 1.
2 Marialis cultus 41.
3 Fil 2,6-8; 2Cor 8,9.
4 Eb 1,6; Gv 1,16.
5 Credo.
6 Lc 1,26-38.
7 Lumen gentium 65.
ASCOLTA L'AUDIO DELL'ARTICOLO
