Un articolo di Gianfranco Belsito in Asprenas 62(2018), pp. 247-264.
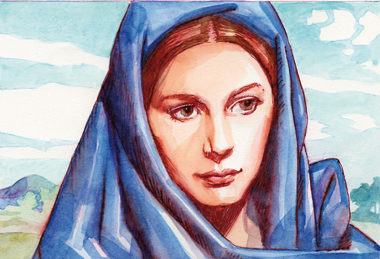
Questo contributo nasce dall’esperienza educativa condivisa con i
giovani del territorio in cui operiamo pastoralmente: si parte dal vissuto
e costituisce solo la prima parte, sintetizzata, di un lavoro di ricerca per
un itinerario giovanile di educazione alla fede attraverso la Via Matris.
Presentiamo, qui, le ragioni teologico-pastorali che stanno alla base di
questa scelta, in quanto la pietà popolare e i giovani non sono realtà contrastanti. La bellezza e il dolore di Maria, come partecipazione ai dolori del Figlio, costituiscono una valida proposta educativa per i giovani. Abbiamo pensato di valorizzare il tesoro prezioso della pietà popolare per
proporre ai giovani del dopo cresima un itinerario di fede imperniato
sulla figura e la presenza spirituale della madre di Gesù. Il corollario pastorale che gli addetti ai lavori hanno in mente è quello che fa corrispondere alla pietà popolare l’immagine della “vecchietta” e, in aggiunta,
si guarda forse ancora alla fede dei semplici come a una fede di basso profilo. In linea di principio, si fa difficoltà ad accostare la pietà popolare al
mondo giovanile. Il nostro compito è di spiegare e documentare perché
la pietà popolare, e in specie qui quella mariana, non debba essere letta
come un binomio dicotomico. Il binomio “pietà popolare-giovani” sarà
utile per consentire a tanti di essi, che si sono allontanati dopo aver celebrato la cresima, di risignificare le problematiche della loro vita.
1. La pietà popolare o mistica del popolo
Papa Francesco, facendo suo il pensiero di Paolo VI1, ci ha ricordato di recente che la pietà popolare «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere e che rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede»2. Da un punto di vista strettamente teologico-pastorale, si è potuto
registrare una duplice tendenza nella lettura della pietà popolare: di rifiuto acritico o di accoglienza remissiva3. Si richiedono nuovi criteri di
approccio, evitando atteggiamenti pastorali radicali, acritici, sia di rifiuto che di accoglienza. Quanto all’atteggiamento pastorale, perciò, bisogna procedere verso una lettura più attenta in vista di una comprensione: «Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo
sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare»4. Essa va sempre più inquadrata come una “mistica del popolo”5 e vi è
sempre più urgente bisogno di una catechesi che ne sveli il ricco valore
esistenziale e il potenziale educativo che ne consegue.
Questa “mistica del popolo” è generata da esigenze vitali ed esprime la creatività che la cultura di un popolo provoca come risposta ad alcuni bisogni, letti alla luce della grazia di Dio, ove il protagonista principale diventa lo Spirito Santo. Non è una fede dal basso profilo intellettuale né, tantomeno, una fede per chi non sa. È la fede del popolo di
Dio. Una vera e propria “teologia del popolo”. Nell’Evangelii gaudium,
papa Francesco precisa che questa fede, intesa come dono di Dio al suo
popolo, viene ricevuta in una cultura e tradotta e incarnata negli usi e nei
costumi di un’etnia situata: «La grazia suppone la cultura, e il dono di
Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve»6. L’esortazione apostolica fa
esplicito riferimento al documento conclusivo dei vescovi dell’America
Latina, dove la pietà popolare è presentata come una «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici»7; essa, come tale, non è priva di contenuti, anzi li produce con il genio creativo proprio della via simbolica
che si caratterizza come il credere in Deum – credere in Dio, ovvero in
senso fiduciale, di fiducia e vicinanza – più che il credere Deum – ossia
credere Dio –, che esprime un senso più intellettuale, come insegna san
Tommaso8. È «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della chiesa, e di essere missionari»9; «dispone immediatamente alla missionarietà, all’uscire da se stessi e all’essere pellegrini»10. «Il
camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in se stesso un atto di evangelizzazione»11. Questo vuol
dire che la fede di ogni popolo è “situata” e, perciò, variegata, dando così vita a una “chiesa dai mille volti”. Questa varietà è data dalla cultura toccata dalla grazia. L’attore principale è lo Spirito Santo, che genera una multiformità di colori e di suoni, dando luogo a una teologia
che si afferma in quanto fondata sull’unità del senso e non dispersa nell’uniformità dell’espressione. Si tratta di saper discernere, nella cultura
di ogni popolo, i segni dell’azione del Paraclito in quel contesto. Il senso della fede di un popolo, quando crede in Dio in modo semplice,
spontaneo e libero, si dimostra infallibile, in forza dell’azione di grazia
ricevuta dallo Spirito di Dio. La categoria teologica che qui si privilegia
è quella del “popolo di Dio” e del suo sensus fidei12. I membri del popolo sono così naturalmente, quasi per istinto, discepoli e missionari. Soggetti attivi di un progetto di salvezza, operato dallo Spirito Santo, che
sviluppa una potente carica missionaria, “collettiva” appunto. La pietà
popolare viene letta come attività spontanea e missionaria del popolo di
Dio, che diviene oggetto e soggetto di evangelizzazione. Si manifesta
qui un’inevitabile attenzione preferenziale per i poveri, che divengono
un vero e proprio “luogo teologico”. Non riconoscere questo sarebbe
come limitare l’azione dello Spirito.
Il Direttorio sulla pietà popolare aveva già operato una precisa scelta semantica13. Il tema della pietà dei “semplici” evidenzia un’attività
favorita e ispirata da Dio che, più che essere inquadrata come fenomeno di sociologia religiosa, va letta come un vero e proprio “luogo teologico”, come un felice incontro sinergico di quattro fattori: il Vangelo,
la cultura, la predicazione della memoria della comunità (in specie del
presbitero) e la forma che assume in un determinato contesto culturale
l’accoglienza della Parola o del mistero del Cristo14. “Popolare” non va
più legato al vago sentimento religioso, ma inteso come più vicino al
linguaggio, tenero e filiale, di un uomo che si rapporta “francamente” e
“spontaneamente” con il Dio Padre. Si tratta di una vera e propria ermeneutica in cui il popolo di Dio legge, attraverso l’aiuto della grazia, la vita, con i suoi ritmi di festa, dolore, angoscia e gioia. In tal modo dialoga con Dio, attraverso la preferenza di un linguaggio simbolico, riconoscibile attraverso i connotati delle diverse culture dei popoli, per incamminarsi verso Cristo, meta del pellegrinaggio della propria esistenza. Il
recente magistero ci guida nell’accogliere le forme della pietà popolare
come orientamento verso una fede non individualista, in quanto segnata dalla relazione con Dio e con i fratelli15. I poveri sono i protagonisti
principali di queste forme di pietà. Perché esse veicolano le povertà dell’umanità: il dolore, la malattia e la morte16.
2. La pietà popolare e la liturgia
La pietà popolare include tutte quelle forme che, pur non appartenendo alla liturgia ufficiale della chiesa, si pongono in armonia con essa17. La “mistica dei semplici” è propedeutica alla liturgia ufficiale della chiesa. Conduce con più forza il popolo di Dio ad aprirsi al mistero
di Cristo per com’è “ripresentato” nella liturgia, che svela nel suo centro vitale il mistero pasquale (cf.
SC 13). La liturgia è la pedagogia con
la quale la madre-chiesa educa i suoi figli, e la pietà popolare non è figlia “spuria”18. Talvolta, la liturgia fa sorgere e guida la pietà popolare
in un’ottica missionaria e ne sviluppa anche una dimensione sociale in
modo inaspettato19. È il caso tipico della Missa pizzianti20, così denominata a Roggiano Gravina (Cosenza), territorio della Valle dell’Esaro. Questa tradizione nasce come atto votivo. In genere, sono le mamme che,
ottenuta la liberazione di un figlio carcerato, si muovono a fare questua,
di casa in casa, tra vicini, parenti e anche al di fuori del proprio rione, chiedendo un’offerta, come questuanti appunto, spiegandone anche le
ragioni: “mio figlio è stato in carcere ma ora è libero e voglio far dire
una Missa pizzianti per lui, come ringraziamento perché sono stata
esaudita nelle mie richieste dal buon Dio”. Apprendemmo di questa pia
pratica da ragazzi, quando, ancora adolescenti, piombò in casa una
donna, non del nostro vicinato, che entrò a piedi scalzi e pose la richiesta con tono di voce alto e pur umile. Non provava vergogna, ma neppure tracotanza. Subito dopo chiedemmo a nostra madre perché quella donna fosse venuta a bussare a casa nostra, e a piedi nudi, per chiedere un’offerta “per far dire una messa”. Mia madre spiegò che le condizioni economiche di quella famiglia erano tutt’altro che povere, ciononostante, quella madre aveva ottenuto una grazia e, nel suo modo di
leggere, riteneva l’accusa ingiusta per il figlio. Voleva, così, far celebrare una messa, raccogliendo l’offerta e muovendo, come una questuante,
a piedi nudi per le vie del paese. Alla celebrazione prese parte nostra
madre e tutti coloro che avevano aderito alle sue richieste. Il voto di
quella madre nacque da due esigenze: la liberazione del figlio, che bruciava in lei come problema esistenziale, e l’esigenza di parlarne con Dio.
Proprio questa volontà di “ringraziamento” ha spinto a maturare l’idea
di compiere un voto, che coinvolgesse tante persone e, insieme, ritrovarsi in una celebrazione ufficiale del sacrificio di Cristo.
L’approdo, nella liturgia, nasce da un problema esistenziale, vivo,
che manifesta il bisogno di dialogare con Dio, proprio come avviene
nella comunità credente. Nella fede del popolo, chiedere al ministro di
Dio di celebrare una messa secondo le proprie intenzioni dispone l’animo del credente a donare un’offerta. Tanto non deve stupire, considerato che l’uso dell’offerta è antico e ha le sue radici nel testo biblico, dove
Gesù stesso dice: «l’operaio ha diritto alla sua mercede» (Lc 10,7; cf.
Tm 5,18; 1Cor 9,7-14)21. Nel gesto dell’offerta sono impliciti più significati:
chi chiede la celebrazione desidera offrire qualcosa di sé, che risulti anche
utile; il sacerdote riceve il dono con spirito di umiltà, nella consapevolezza che esso vale come elemosina, offerta in partecipazione al sacrificio di
Cristo e per le necessità della chiesa, cioè dei poveri, e del sacerdote
stesso che celebra quel mistero per il popolo. Estendendo l’analisi, la
mamma, ottenuta la grazia, si reca di casa in casa, compiendo un gesto
di gratitudine e insieme di pietà: gira a piedi nudi, a contatto con la nuda terra, quasi che questa, come sorella e madre, si renda partecipe della gioia per il pericolo scampato; ed è festa per la grazia ottenuta. Si uniscono motivi di penitenza pubblica, che rendono la madre, al tempo
stesso, missionaria e apostola della celebrazione eucaristica. La comunicazione qui avviene senza parole, perché vi sono gesti che dicono
molto di più delle parole, ed è come se, quella madre, con il suo incedere scalzo, dicesse: sono a piedi nudi, perché ho sofferto per la privazione del figlio; so che nel silenzio mi siete stati vicini e, pur nella sofferenza, voglio rendere lode al Signore nel sacrificio di Cristo sull’altare.
Del resto, anche Gesù ha conosciuto l’umiliazione del carcere: «Allora
i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù,
lo legarono» (Gv 18,12). Egli, in assoluto, “comprende” lo stato d’animo di quella donna e di suo figlio. Cristo ha donato la sua vita per i suoi
figli. Quella madre vive una sofferenza che trova nel sacrificio di Gesù
pieno senso. La messa è l’offerta del sacrificio del Figlio per i figli. Da
quel Cristo si sentirà ripetere il Vangelo della misericordia: coraggio,
prendete parte con me alla gioia dello stare insieme, della liberazione
«perché ero carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,36).
L’evangelizzazione qui acquista un indubbio valore sociale, come
fatto doloroso che diventa condiviso per un alto scopo, di evidenza comunitaria: rendere lode al Signore per la liberazione ottenuta. Nel gesto
della richiesta dell’offerta, da parte della mamma protagonista dell’episodio esaminato, e in quello della corresponsione allo stesso, da parte di
più persone, prende corpo quella pietà popolare, in cui, di fatto, si concretizza la riabilitazione sociale e comunitaria, grazie all’opera di misericordia, elemosinata di casa in casa, di volto in volto, e condivisa. In questa pia pratica, oggi ripresa dall’attuale parroco che celebra questa messa solo nella chiesa del Calvario, dove il Venerdì santo si vive la passione
del Figlio, si condensano elementi di umanità vera, propria di chi non
nasconde i propri drammi esistenziali a Dio e ai fratelli. In quest’orizzonte sembra di sentire la Vergine delle nozze di Cana: quando viene a
mancare il vino della gioia nella vostra vita andate da Cristo e fate quello che vi dirà (cf.
Gv 2,5).
3. La pietà popolare e i giovani: un felice binomio
La pietà popolare ha in sé degli elementi propri per ciò che concerne la sua strutturazione e la sua forma culturale che sono particolarmente adatti al mondo giovanile. Tant’è che nella prassi consolidata della pastorale tout court, i protagonisti della pietà popolare sono proprio le
giovani generazioni. Sono essi ad animare le feste e le tradizioni locali22.
Alcune analisi del passato hanno già mostrato come il binomio
“pietà popolare-giovani” costituisca un polo forte di attrazione degli
studiosi della materia. Se da una parte vi si leggono motivi ostativi, dall’altra si colgono anche punti di forza. In un passato ancora recente già
si rilevava come spesso i principali attori della pietà del popolo di Dio
fossero soprattutto i giovani23. È emblematica in tal senso l’animazione
della settimana santa a Belvedere Marittimo (Cosenza), a cura dei giovani, che, avendo ricevuto la tradizione dei fratilli dai genitori o, addirittura, dai nonni, avvertono l’impegno a ripeterne le gesta. Altrettanto
avviene nella generalità delle parrocchie dove i giovani animano il presepe vivente a Natale o la drammatizzazione della passione. Sono forme
che si configurano in modo evidente come religione del popolo.
A esserne protagonisti sono quei giovani che, pastoralmente, risultano essere il problema più rilevante della chiesa, dal momento che, dopo la cresima, spesso abbandonano la vita parrocchiale, sia pur in modo
non sempre definitivo, inteso come rottura totale. Il fenomeno dell’allontanamento avviene a motivo di una certa disaffezione verso la chiesa,
intesa come istituzione. Tuttavia, conforta sapere che più del 50% di essi stima la vocazione dei preti espressa nell’impegno in parrocchia24.
Sebbene la parrocchia non sia più l’alveo naturale come organizzazione sociale del nostro tempo, non si può certo dire che la “fontana del villaggio” abbia cessato di svolgere la sua funzione educatrice. A proposito del post cresima, recenti indagini hanno messo chiaramente in luce
come i figli del terzo millennio non abbiano reciso il cordone ombelicale con la parrocchia. Anzi, essi ne parlano come di un ricordo caldo e significativo della loro vita d’infanzia e adolescenziale. Addirittura, vi ritornano a tratti alterni25. Quest’indagine qualitativa ha evidenziato come
la cresima, pur provocando un momentaneo abbandono, che coincide
con l’inizio delle scuole superiori e, in più larga misura, con l’ingresso
negli studi universitari, non possa comunque essere definita come un
“addio”, considerando che spesso vi ritornano. Seguendo quella linea
tracciata dall’indagine citata in nota, si vede bene come vi siano diversi
motivi che muovono verso un ritorno alla vita parrocchiale e, in generale, alla fede, intesa come questione di senso della loro vita che continua a interessarli. Non si cancella il ricordo felice delle esperienze significative vissute in parrocchia; al tempo stesso, la figura di papa Francesco affascina e convince per la testimonianza e l’autenticità delle parole. Inoltre, i nonni esercitano un richiamo alle tradizioni sacre, quali,
ad esempio, la pratica del pellegrinaggio. Tutto questo crea un circolo
virtuoso che riconduce i giovani nell’alveo della vita parrocchiale. Il pellegrinaggio dei giovani verso i luoghi della fede non rimane occasionale,
perché l’epoca digitale offre, a portata di click, la possibilità di visitare
continuamente quelle mete. Basti vedere cosa succede con Santiago di
Compostela, il cui sito è continuamente postato dai giovani sui social.
La presenza dei giovani in parrocchia richiede un’efficace organizzazione della proposta pastorale, istituendo specifici incontri con le famiglie, e richiedendo la presenza dei nonni. La scelta di differenziare
questi incontri per fasce d’età non sempre si è rivelata fruttuosa. Si ritiene di dovere potenziare tali incontri coinvolgendo le diverse età. Nella
differenziazione della proposta per fasce d’età sicuramente si parla un
linguaggio più adatto alle esigenze e attese del mondo giovanile. Tuttavia, in tal modo ci si priva della presenza dei genitori e dei nonni, punti
di riferimenti imprescindibili per un cammino di crescita. La pedagogia ci ha mostrato quanto siano fruttuosi, educativamente parlando, i processi d’identificazione, i modelli di riferimento. Tra questi, prima fra
tutti, la famiglia. Una linea pastorale che possa inseguire i giovani e i
nonni e, più in generale, la famiglia, non appare così infondata. Sono i
dati a metterlo in luce e, talvolta, alcune espressioni riportate proprio
dai giovani ci convincono ancora di più26.
La società complessa non rende certo agevole una proposta di fede
per i giovani che reclamano di sentirla propria, vicina, calda, significativa. In questo senso la pietà popolare ha tutto ciò che serve per appassionare i giovani. Troviamo conferma nel documento preparatorio sul
Sinodo dei giovani: «la riscoperta del pellegrinaggio come forma e stile
di cammino appare valida e promettente; in molti contesti l’esperienza
della pietà popolare sostiene e nutre la fede dei giovani»27. Viene loro
trasmessa da persone che stimano come credibili e significative. In alcune rappresentazioni dei dolori di Cristo, sono i giovani che interpretano figure di statuanti, riscoprendo cosi un sano protagonismo che
non poche volte viene vissuto con carico di pathos. Il loro essere protagonisti dei riti non è tanto un voler apparire. Accogliendo ciò che è tramandato dai genitori e dai nonni come eredità del passato, di cui diventano responsabili e attori, i giovani, in qualche modo, rivendicano
un ruolo di protagonismo ambientale che non viene loro riconosciuto.
Ma attraverso quella simulazione rappresentata dell’esperienza della
croce c’è, più di tutto, il voler fare propri i sentimenti e il cuore del personaggio interpretato. Questi momenti sono lungamente preparati e attesi da tutta la famiglia e i giovani li vivono con un particolare carico
emotivo, che difficilmente viene dimenticato. Si è fatto osservare, con
intelligenza e acume pastorale che, sovente, questi itinerari conducono
alla scelta vocazionale. I giovani che entrano nei seminari non scendono
dal cielo ma sono pienamente inseriti nella vita della comunità parrocchiale e «la forma del cattolicesimo popolare fa parte del loro dna»28.
Ogni santuario mariano presenta caratteristiche proprie dell’ambiente e della cultura in cui si vive. I racconti di questi pellegrinaggi si sono appresi in tenera età e non si vede l’ora di poter verificare di persona quanto ascoltato dai racconti dei propri familiari. Esteticamente non
può definirsi ortodosso, ma è invalso l’uso dei giovani di scrivere sulle
pareti dei santuari la propria preghiera, la richiesta di protezione o il
ringraziamento. Anche queste analisi richiederebbero ben altro spazio e
siamo certi che rivelerebbero tutta la complessità e l’autenticità dell’animo giovanile, “toccato” dalla grazia.
La fede non è frutto della sola intelligenza umana e non si può ridurre a fatto intellettuale. È esperienza di grazia che riscalda direttamente i cuori. Non dobbiamo avere paura di presentare esperienze che
toccano direttamente il cuore dei nostri figli. I semplici, come già ebbe
modo di dire Paolo VI, saranno capaci di vedere Dio. Esperienze, dunque, che coinvolgono i sensi dell’uomo e che per questo affascinano e
seducono i giovani e vanno seguite con intenzionalità educativa. La pedagogia scout, in tal senso, come proposta di educazione attraverso la
dinamica esperienza-simbolo-concetto, ha fatto della rappresentazione
una chiave educativa che produce i suoi frutti da tempo29.
Non è certo un mistero che la pietà popolare dà modo al genio locale e giovanile di esprimere il proprio mondo interiore, rielaborando
nella cultura di appartenenza le tracce depositate dallo Spirito Santo
nell’animo del giovane credente. Molte volte, a torto, si è ritenuto che i
giovani fossero privi di valori. I dati di molte inchieste rivelano il contrario: giudicano l’amore, l’amicizia e la famiglia come le cose più importanti30. Per i
millennials31 non vi è spazio per norme a carattere universale o, comunque, non sperimentabili nell’esperienza del singolo.
Vanno proposte esperienze nel segno della fede, capaci di far maturare
una nuova sintesi.
L’idea di presentare Maria ai giovani, inseriti nel loro contesto, deve trovare un linguaggio appetibile nella linea di un sano protagonismo
dei ragazzi, perché cosi potranno scoprire, come in uno scrigno, anche
il bisogno di un’etica, di una norma e di un carattere universale della
propria storia.
4. Maria: una proposta per i giovani
Giovanni Paolo II, in occasione della XVIII Giornata Mondiale della Gioventù, rivolse un messaggio ai giovani proponendo
Maria come
modello di spiritualità giovanile32. I nostri giovani hanno bisogno di
riscoprire la spiritualità di Maria, giovane donna, umile e coraggiosa
insieme, disponibile al sacrificio e capace di speranza, dinamica nel
servizio attivo e desiderosa di comprensione. Ella è un soggetto attivo e protagonista di un progetto di salvezza per tutta l’umanità, pensato da Dio, realizzato dal Cristo per opera dello Spirito Santo. Sono proprio i tratti umani della Vergine che accomunano la giovane fanciulla
della città nascosta di Nazaret alle giovani generazioni della postmodernità.
Dopo duemila anni di storia, Maria si dimostra ancora giovane,
come se il tempo non l’avesse scalfita. Alcune immagini bibliche ci autorizzano a pensare in tal senso: giovane, perché non preceduta dalla
fama o dall’appartenenza a una casta di ascendenti; “feriale”, direbbe
il compianto monsignor Tonino Bello, Maria è raggiunta dall’annuncio
dell’angelo a Nazaret, città anonima e laica del tempo; Madre, che nel
Vangelo di Luca, al momento del concepimento, è presentata come
una fanciulla ancora integra, cioè Vergine (cf. Lc 1,26-38); generosa,
come solo i giovani sanno essere, quando compie diversi chilometri a
piedi da Nazaret ad Ain Karim per visitare Elisabetta; la gioia di questa giovane donna si esprime nel canto di lode del
Magnificat, dove risulta essere proiettata verso un futuro pieno di speranza. Nel canto del
Magnificat si vede bene come questa ragazza, più che subire la logica
del mondo, la vuole cambiare in una storia di pace, vuol essere “nel
mondo ma non del mondo” come coraggiosa artefice di cambiamento,
ed è per questo che accetta la vocazione (cf. Lc 1,38). Il sogno e il progetto di rovesciare la logica del mondo non passano per le linee della
protesta o dei no-global, ma passano per le vie di un equilibrio psicofisico di una giovane la cui attività viene sempre preceduta dalla riflessione: «Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore […]. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo
cuore» (Lc 2,19.51). Insieme alla fede, proprio davanti all’angelo, ha cercato le ragioni per credere. La fede di Maria non è, dunque, spiritualismo cieco o fideismo. L’atto di fede di Maria, come abbandono fiducioso nelle mani del Padre, richiama l’idea dell’“intelligenza della
fede”.
Il mistero dell’Assunta è quello che la consacra giovane per sempre: il corpo “glorificato” (cf.
1Cor 15,40-46), sganciato dalle coordinate spazio-temporali, rimane sempre giovane. La fanciulla di Nazaret
è modello non perché è giovane, ma perché ha saputo realizzare quanto
propose e attuò lo stesso Gesù. Pertanto, potrebbe essere davvero utile strutturare degli itinerari educativi di spiritualità mariana per i giovani33.
L’iconografia orientale ha reso plasticamente quest’idea, perché non
rappresenta mai Maria senza il bambino; in tal caso, sarebbe come “una
lampada senza luce”. Bisogna sempre vivere con gli stessi sentimenti che
furono di Cristo Gesù (cf. Fil 2,5). In Cristo possiamo parlare sicuramente di due dimensioni: la figliolanza divina e l’amore per gli uomini,
suoi fratelli. Con l’espressione “avere gli stessi sentimenti di Cristo” non
si vuole certo alludere al fugace e passeggero sentimentalismo dei giovani quanto, piuttosto, a quel sentimento da cui nasce l’azione e il progetto di vita. Quel sentimento che deve essere custodito e curato nella preghiera quotidiana, proprio come ha fatto Gesù.
È ancora Giovanni Paolo II a ricordarci quanto segue a proposito
di Maria: «Ella ci immette in modo naturale nella vita di Cristo e ci fa
come respirare i suoi sentimenti»34. In altri testi, quasi continuando la
medesima riflessione, ci riferisce che nella celebrazione eucaristica, in
un certo modo, noi riceviamo sempre, con il memoriale della morte di
Cristo, anche il dono di Maria, che ci è stato fatto dal Crocifisso nella
persona di Giovanni («ecco la tua madre»: Gv 19,27). «Vivere nell’eucaristia il memoriale della morte di Cristo implica anche ricevere continuamente questo dono»35. Maria è una donna pienamente riuscita e questo affascina e attrae
il mondo giovanile, che vede in lei i tratti umani di una donna la quale, come tutti, deve avanzare progressivamente nella fede. Vive in un
ambiente modesto e di lavoro quotidiano, più che di rendita. Non appartiene alla casta dei protetti. Sono i tratti umani della donna di fede che
affronta il suo cammino di credente come tutti i fedeli, senza ritenere di
poter trovare una scorciatoia. Non va in ansia quando perde il suo amabilissimo bambino nel tempio e non passa ad accusare Giuseppe. Si dimostra attenta all’impegno sociale verso tutti i bisognosi del mondo
quando si reca a fare volontariato per un lungo periodo dalla cugina
Elisabetta. Creatura intelligente, coraggiosa, che non si risparmia nella
fatica quando è costretta a far nascere suo figlio in una grotta. Soprattutto, si rivela esigente nella giustizia sociale e piena di gioia quando eleva il suo cantico di lode nella preghiera del Magnificat. Esso è denuncia
profetica contro i prepotenti di turno. È un solco chiaro e netto per
sdoganare la fede dalle sacrestie36.
Non si può cedere alla disaffezione verso la politica e l’impegno sociale. Ascoltare la voce di un Dio, che continua a chiamare, significa ricevere l’esempio di Maria che ci invita a diventare “parte attiva” del
mondo in cui viviamo.
Maria è proprio una giovane donna che compie il suo cammino di
fede umano su questa terra. Gode sì di favori divini, ma la sua umanità
è vera e spontanea. Il turbamento di fronte all’angelo che le annuncia
la nascita prodigiosa ci viene narrato dal terzo Vangelo. Ma come non
immaginare il suo imbarazzo nell’incrociare il volto dubbioso di Giuseppe (cf.
Mt 1,19)? Anche qui Maria, proprio per la sua personalità di
parte attiva, avrà raccontato a Giuseppe ogni cosa nei minimi dettagli
e avrà chiesto per questo anche l’aiuto di Dio come fa ogni credente
nei momenti difficili. In questo si può leggere anche l’intervento dell’angelo che, nel sogno, fuga ogni dubbio di Giuseppe (cf.
Mt 1,20-23).
Come ogni donna, con il suo istinto materno e con le parole di Simeone al tempio, comprende che crescere un figlio vuol dire essere disposti a partorirlo mille volte, che la sua missione non si risolverà tutta in un trionfo, che la luce luminosa della sua presenza sarà unita al dolore.
5. Le due vie: la bellezza e il dolore
L’idea di presentare la via della bellezza o dei doni che Maria ha ricevuto da Dio vuole essere un modo per ripercorrere i motivi per cui
quell’umile fanciulla venne eletta da Dio a questa missione.
La Tutta Bella è, perciò, quella porta che conduce agevolmente i nostri giovani a Cristo. La «piena di grazia» o la «graziosissima»37 è colei
che rivela tutto il suo fascino e fulgore in quanto pienamente immersa
nel fuoco della passione del suo Figlio. L’itinerario di Maria, educatrice
del suo bimbo, la porta a vivere talvolta in anticipo il tema della passione, della croce e della pasqua38. La “spada”, di cui ci riferisce il
Vangelo di Luca (2,34), va letta come quella parola di Dio, dello stesso
Gesù che, così, educherà sua madre nelle diverse fasi del suo cammino
di discepolato, al senso del distacco dall’amore umano, per cogliere,
sempre di più, l’amore di Dio39. Anche quest’esperienza del distacco,
in ragione del Figlio, Maria la vive in anticipo. Sicuramente, nel canto
di una Madre che pronuncia nuovamente il suo sì alla vita ogni volta
che compie scelte per educare suo figlio a una vita autonoma. Ogni
madre sa, in cuor suo, che donare alla luce un figlio vuol dire staccarlo
da sé. L’esperienza naturale del concepimento ha fatto in modo che la
madre sentisse quel bimbo crescere nelle sue viscere. Ha dovuto vegliarlo e, dopo averlo custodito e protetto per nove mesi, ha lottato ancora e sofferto per portarlo al mondo. Si può facilmente immaginare
Maria che lo accompagna nei primi anni della sua esistenza terrena:
«Da una parte lo comprende dentro il suo corpo arcuato e lo sostiene
per le fragili braccia, dall’altra guida i suoi passi lontano da lei, verso il
mondo»40.
In questo sta la bellezza della giovane Madre che non lega suo figlio
a sé. Nel prendersi cura di lui, lo abilita a vivere la sua missione. Abilitava suo figlio a manovrare quella spada del distacco quando consegnava la sua voce alla Parola fatta carne. Sì, perché il bimbo Gesù, come
ogni uomo, veramente uomo, ha dovuto scoprire il mondo attraverso la lingua41 della madre. Ogni bimbo, quando, ancora neonato, non parla, si nutre e filtra tutto attraverso gli occhi della madre che diventano
uno specchio verso il mondo. Solo la mamma ha saputo decifrare ogni
gesto del bimbo attraverso il nutrimento del corpo, fatto di strilli, pianti, fino a far scaturire in lui il miracolo della parola. Il miracolo della
parola umana nel bambino, il suo cammino educativo e il forte senso di
responsabilità hanno fatto sì che lentamente maturasse in lei l’atteggiamento del discepolato42.
Si dovrà dire di più: i doni ricevuti dalla giovane di Nazaret, dunque, si spiegano in tutta la loro valenza in funzione della croce e, precisamente, sotto la croce. Il Figlio di Dio consegna la madre alla chiesa
del discepolo prediletto e il discepolo amato a lei43. Maria è consegnata alla chiesa locale quale Madre dell’intera umanità. La croce preannunciata dal vecchio saggio Simeone si realizza pienamente sotto la croce, dove anche il Figlio “imparò dalle cose che patì” e si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Cristo, su quell’altare di legno,
offre la sua vita, tutto il suo amore e la madre, dunque, fu più volte respinta perché potesse accoglierlo nel suo splendore di uomo respinto,
ferito ai piedi di quell’albero maestro. Fu più volte rifiutata dal figlio,
perché potesse capire il rifiuto umano del Figlio sotto la croce. Anzi,
l’immacolata concezione, l’incarnazione e tutto il percorso di progressiva assimilazione della madre al figlio si spiegano solo in croce e la sua
vera bellezza e fulgore qui solo si rivelano pienamente44.
La bellezza del Crocifisso rende bella la sua sposa-donna-madre. Il
fuoco della passione del Figlio rendono luminosi i tratti umani della giovane donna che si lascia educare e portare dal figlio. È l’ora della croce
che ha portato la madre a presentare il suo bimbo al tempio; è l’ora della croce che l’ha condotta in Egitto; l’ha sospinta a Cana di Galilea; l’ha
distanziata insieme ai parenti per poterla portare con sé, definitivamente, sotto la croce e quindi poi al cielo con l’assunzione. In un felice mutuo scambio di doni: la madre l’ha portato alla luce del mondo e il figlio l’ha condotta alla beatitudine eterna dell’assunzione. L’itinerario
della gloria (o della bellezza) e della croce, come partecipazione di Maria ai dolori del Figlio, vanno tenuti insieme. La gloria di Maria proviene da quel “sì” pronunciato al messaggero del Padre che le annunciava
la nascita del Redentore, ma soprattutto in vista di quel “sì” confermato e ripetuto sotto la croce, quando accetta il discepolo amato come suo
figlio.
La sua bellezza sta tutta nel rivelare la bontà e verità di un Dio che
ha voluto raggiungere l’umanità nella storia. La bellezza di Maria è, perciò, universalmente riconosciuta nelle tante devozioni delle chiese locali, che sicuramente costituiscono il frutto del genio della cultura di un
popolo che si lascia contagiare dalla donna-vergine-Madre.
L’apprezzamento di questa bellezza non è solo cattolico, che di per
sé è già universale, ma si fa corale e sinfonico grazie al contributo di altre religioni. Nel
Corano, ad esempio, pur non ritenendola Madre di
Dio, si riconosce in lei un’eletta (cf. Corano 3,33) su tutte le donne del
creato e (il Creatore) l’ha purificata (cf. Corano 3,42) perché potesse
soggiornare al tempio e la sua preghiera fosse più gradita. Ma già prima della sua stessa nascita Maria fu consacrata a Dio da sua madre:
«Oh Signore! Io voto a Te ciò ch’è nel mio seno sarà libero dal mondo
e dato a Te! Accetta da me questo dono, che Tu sei Colui che ascolta e
conosce» (Corano 3,35). Più avanti si testimonia ancora come la si voglia ritenere libera dal potere di Satana, nemico di tutti gli uomini. Secondo la tradizione islamica, Maria e Gesù fanno parte di quegli uomini prescelti da Dio e che sono stati sottratti alla puntura di Satana
(cf. Corano 38,82s). Anche l’islam ritiene Maria, perciò, tutta bella,
priva di ogni macchia di peccato in ragione di suo figlio Gesù. Ed è
ancora per questo motivo che l’islam la contempla Vergine e Madre.
Quando lei riceve l’annuncio della nascita di un figlio, nel libro sacro dell’islam, chiede: «Come potrò avere un figlio, se nessun uomo m’ha toccata mai e non sono una donna di cattivi costumi?» (Corano
19,20). Le
allusioni al testo di Luca sono fin troppo evidenti. Nel Corano, a differenza del testo biblico, è evidente la decisione di Maria che non aveva mai pensato di diventare madre, facendo pensare a un voto di castità, e la sua maternità si spiega solo con l’intervento divino che ne
preserva l’integrità verginale. L’interlocutore divino stesso le risponde: «Cosa facile è per me questa» (Corano 19,21). Si vede anche qui come la bellezza di Maria risulti intatta e incontaminata persino dopo la
maternità, che non sconvolge il suo piano di verginità.
Gloria e croce costituiscono gli elementi validi ed efficaci di un itinerario di catechesi giovanile ispirato a Maria.
NOTE
1 Nell’Evangelii nuntiandi, Paolo VI indica gli aspetti positivi della
“pietà popolare”. Cf. PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi
(8-12-1975), n. 48: AAS 68 (1976) 5-76, qui 37-38.
2 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24-11-2013), n.
123: AAS 105 (2013) 1019-1137, qui 1072 [d’ora in poi EG].
3 Per una ricognizione dei diversi approcci della teologia alla pietà popolare
si potrà consultare S. DE FIORES, Figura biblica di Maria e sua
inculturazione popolare, in Atualidade Teólogica 14 (2010) 4,
293-300.
4 EG 115.
5 L’espressione è riferita da EG 124, anche se, in realtà, riprende un
tema che era già stato sviluppato dallo stesso Bergoglio in un documento (V
Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, Documento di
Aparecida [29-6-2007], 164 [d’ora in poi DA]) dove si faceva riferimento
a una spiritualità dei semplici che incarnano il Vangelo nella cultura locale.
6 EG 115.
7 DA 263.
8 Cf. EG 124.
9 DA 264.
10 EG 124.
11 DA 264.
12 Per una puntuale ricognizione del sensus fidei nella storia si veda Y.
CONGAR, Per una teologia del laicato, Brescia 1966, 372-411.
13 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI,
Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del
Vaticano 2002. In questo documento si distingueva nettamente la “religiosità
popolare”, dimensione religiosa che si trova nel cuore di ogni persona, come
nella cultura di ogni popolo (cf. n. 10), e la “pietà popolare”, intesa
come manifestazioni cultuali di carattere privato (cf. n. 9).
14 Cf. I. SCHINELLA, Cattolicesimo popolare. Una sfida per il terzo millennio,
Napoli 2007, 6.
15 Cf. EG 90.
16 Cf. EG 125.
17 Cf. Direttorio su pietà popolare e liturgia, 7.
18 La pietà popolare come qualifica di “luogo teologico” è stata
inquadrata non solo come propedeutica ma, addirittura, come esempio e modello
per la stessa liturgia. Cf. I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno
liturgico: le due mani dello Spirito Santo, in Rivista Liturgica 103
(2016) 3, 9-39.
19 Rispetto alla dimensione sociale della liturgia si era già efficacemente
pronunciato papa Montini. Cf. PAOLO VI, Lettera enciclica Misterium fidei
(3-9-1965), nn. 69-70: AAS 57 (1965) 751-774, qui 772. Il termine “liturgia”,
poi, proviene dal greco ed è composto da due parole: laós (“popolo”) ed
ergon (“opera”). Più che essere opera del singolo, la liturgia «è
opera del popolo»: R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia. I santi segni,
Brescia 1996, 17.
20 Tradizione del nostro paese natio, Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza.
L’espressione letteralmente è da tradursi così: “la messa dei pezzenti”.
21 L’uso della compartecipazione dei fedeli mediante elemosine al sacrificio di
Cristo ha un rimando antico ed è stato ben spiegato da papa Montini: «Tale
uso, col quale i fedeli si associano più intimamente a Cristo offerente e ne
percepiscono frutti più abbondanti, è stato non solo approvato, ma anche
incoraggiato dalla chiesa che lo considera come una specie di segno di unione
del battezzato con Cristo, nonché del fedele con il sacerdote, il quale proprio
in suo favore svolge il suo ministero» (PAOLO VI, Lettera apostolica
Firma in traditione [13-6- 1974]: AAS 66 [1974] 308-311, qui 308).
22 Cf. S. DE FIORES, Tratti per una spiritualità giovanile ispirata a Maria,
in Note di Pastorale Giovanile 5/1994, 14-22; L. A. GALLO, Una
spiritualità “mariana” per i giovani d’oggi?, ivi 4/1993, 36-45. Più di
recente un valido contributo sottolinea come sia utile raccogliere la sfida
pastorale che deriva dalla pietà popolare proprio in ambito giovanile in
Calabria. Cf. I. RAUTI, Accogliere la sfida. Il rinnovamento della pastorale
giovanile in Calabria di fronte alle provocazioni della pietà popolare,
Terlizzi (Bari) 2010.
23 Cf. V. ORLANDO, Giovani e religiosità popolare tra tradizione e mutamento,
in Note di Pastorale Giovanile 3/1987, 3-22. Tenendo conto di altri studi
pubblicati proprio sul binomio giovani e Maria qualche decennio fa, cf. V.
ORLANDO - M. PACUCCI, Una devozione mariana tra i giovani? Da un’indagine tra
gli studenti del Sud alcuni interrogativi e verifiche, ivi 4/1993, 7-12.
24 Cf. S. PALMISANO, Dio chiama: chi risponde? Riflessioni sulla vocazione
religiosa, in F. GARELLI (cur.), Chiamati a scegliere. I giovani italiani
di fronte alla vocazione, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, 95.
25 Cf. R. BICHI - P. BIGNARDI (curr.), Dio a modo mio. Giovani e fede in
Italia, Milano 2015. In quest’indagine è rilevato un altro dato
interessante: i giovani tornano in parrocchia non tanto perché hanno avuto un
inserimento nella comunità parrocchiale. Sono le figure significative di
sacerdoti e catechisti che li spingono a ritornarvi. Hanno massima stima di quei
pastori che sentono “l’odore delle pecore”.
26 Cf. BIGNARDI, Conclusioni, in ivi 175.
27 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html#Gli_ambiti_specifici_della_pastorale
[ultimo accesso: 9-4- 2018].
28 SCHINELLA, Cattolicesimo popolare, 52.
29 Cf. P. BERTOLINI - V. PRANZINI, Pedagogia scout. Attualità educativa dello
scautismo, Roma 2011, 89.
30 Cf. M. POLLO, Essere giovani nella seconda modernità - 1. Le
trasformazioni socioculturali, in Note di Pastorale Giovanile 8/2006,
8-9.
31 Con millennials s’intendono i giovani nati tra gli anni Ottanta e i
primi anni del Duemila nel mondo occidentale.
32 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della
Gioventù (13-4-2003): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVI/1, 327-328.
33 A tal proposito, si possono vedere i seguenti contributi nel fascicolo 4/1993
di Note di Pastorale Giovanile, dedicato a Maria nella spiritualità
giovanile: R. TONELLI, Maria nell’itinerario educativo-pastorale (46-55);
D. SIGALINI, Maria nell’esperienza di gruppo. Proposte per la vita dei gruppi
giovanili (56-58); G. DANNEELS, La Madre di Gesù ha qualcosa da dirci?
(59-62).
34 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae
(16-10-2002), n. 15: AAS 95 (2003) 5-36, qui 14.
35 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ecclesia de eucharistia
(17-4-2003), n. 57: AAS 95 (2003) 433-475, qui 471.
36 Cf. A. PALMESE, Maria “povera”. Prospettive di mariologia sociale, in
A. LANGELLA - G. FALANGA (curr.), La figura di Maria nella predicazione e
nella pietà oggi, Napoli 2013, 31-50.
37 T. BELLO, Maria, donna dei nostri giorni, Milano 1993, 106.
38 Cf. I. SCHINELLA, Maria, eredità della Terra, Vibo Valentia 1994,
47-54.
39 Cf. A. SERRA, Maria secondo il Vangelo, Brescia 1988, 112-119.
40
S. VEGETTI FINZI, Il bambino della notte. Divenire donna, divenire madre,
Milano 1990, 254.
41 Con quest’espressione, fa notare lo scrittore, non è da intendersi il
linguaggio ma la lingua «fatta di carne perché composta dalla lingua del
corpo che risulta irriducibile ad elementi grammaticali»: M. RECALCATI,
Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, Milano
2015, 46-47.
42 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Il tutto nel frammento. Per una teologia della
storia: ecco l’uomo, Milano 1972, 204-205.
43 Cf. I. SCHINELLA, La “Madre di Gesù” Madre del “Discepolo amato”. Maria
Madre nello Spirito del sacerdozio di Cristo e dei cristiani, Soveria
Mannelli (Catanzaro) 2009, 23-67.
44 Cf. F. MANZI, La bellezza di Maria. Riflessioni bibliche, Milano 2005,
78.